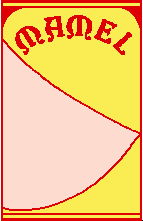Questa, ormai, è storia antica. Ma credo che valga la pena di riparlarne – perché (anche se in modo diverso) problemi di questo genere si presentano ancora oggi.
Nel 1966 Rosser Reeves, nel suo libro Reality in Advertising (che in parte è discutibile o superato, ma contiene molte osservazioni fondamentali e tuttora di attualità) scriveva:
«Una delle cose che mi sorprendono di più è vedere quanti stranieri sono convinti che i pubblicitari d’America si servano delle tecniche freudiane del profondo. Sono persuasi che noi facciamo fare al pubblico quello che vogliamo; che abbiamo scoperto le profonde sorgenti pre-edipiche; che pratichiamo qualche misteriosa magia nera. Come sanno tutti i migliori pubblicitari, queste sono pure e semplici sciocchezze».
Di che cosa stava parlando?
Se risaliamo a quei lontani tempi, scopriamo che era di moda una cosa chiamata “ricerca motivazionale”. Il suo principale profeta era un professore austriaco che di chiamava Ernest Dichter. Sosteneva che usando la psicanalisi si potevano individuare le “motivazioni profonde” dei consumatori e così determinare il posizionamento di un prodotto e orientare la sua comunicazione.
L’ipotesi non è radicalmente sbagliata, in teoria; e la psicanalisi, se bene applicata, è una scienza seria. Ma per molti motivi, che sarebbe lungo approfondire qui, il metodo non funziona, nel modo in cui si è tentato (e ancora si tenta) di applicarlo alla pubblicità o più in generale al marketing e alla comunicazione d’impresa. E anche quando funziona può facilmente portare a percorsi esageratamente e inutilmente complessi. Insomma esistono altri metodi di ricerca e di analisi, sostanzialmente più semplici, che permettono di ottenere risultati molto migliori.
Ernest Dichter e la sua scuola produssero clamorosi disastri. Il più famoso è il fiasco della Ford Edsel (1958-1960) che fu lanciata in base alla teoria dichteriana che un’automobile è una metafora sessuale (maschile) e fallì miseramente sul mercato. Dopo alcuni episodi di questo genere il bizzarro professore perse ogni credibilità negli Stati Uniti. Circolarono nelle più importanti multinazionali direttive che mettevano in guardia contro l’uso di tecniche di quel tipo.
Insomma la faccenda sembrava chiusa; ma il professor Dichter cercò fortuna in Europa e purtroppo la trovò. Potrei raccontare alcuni episodi (divertenti per tutti, fuorché per le imprese o organizzazioni che ne rimasero vittima) di catastrofi, anche italiane, dovute ai suoi dissennati consigli (o a quelli dei suoi seguaci). Quel che è peggio, fece scuola: trovò in diversi paesi, compreso il nostro, imitatori che svilupparono varie teorie e tecniche sotto il nome generico di “ricerca motivazionale”.
Anche se nessuno ne parla più, rispuntano spesso varianti dello stesso genere di teorie e pratiche, con non minori rischi per chi se ne lascia affascinare.
Mi sembra perciò che questo piccolo pezzo di archeologia, oltre ad avere forse un interesse storico, possa avere qualche utilità attuale.
Le teorie di Dichter e dei suoi simili ebbero anche un altro effetto: quello di spargere fra i “non addetti ai lavori” la confusa e sbagliata percezione di cui parlava Rosser Reeves.
Fra le tante sciocchezze scritte sull’argomento c’è un libercolo di un cattivo giornalista americano, tale Vance Packard: The Hidden Persuaders, che uscì all’inizio degli anni ’60 e nel suo paese d’origine ebbe poca fortuna. Ma fu tradotto in italiano con il titolo “I persuasori occulti” e l’errore di traduzione creò un mito che sopravvive ancora: l’esistenza di qualcosa di misterioso, “occulto” e magico con cui si può convincere la gente a fare il contrario di ciò che vorrebbe. Chi si è occupato seriamente di pubblicità o comunicazione d’impresa sa che sono fanfaluche, ma la leggenda continua a circolare. E c’è perfino gente che si occupa di pubblicità e crede, o finge di credere, di avere chissà quali poteri esoterici.
Venne così un giorno in cui decisi di affrontare apertamente il problema. Non sono sicuro che fosse nel 1968, perché non ho più una copia della rivista in cui uscì; ma sono passati circa trent’anni.
La teoria delle “ricerche motivazionali” era allora così forte che non sarei stato creduto se avessi detto semplicemente ciò che pensavo (e ancora penso): cioè che è meglio, semplicemente, buttarle via. Era anche una definizione confusa, che comprendeva le elucubrazioni bizzarre insieme ad altre tecniche un po’ più attendibili. Mi limitai perciò a un invito alla prudenza, con un titolo che può adattarsi a qualsiasi specie di ricerca:
Le ricerche “motivazionali”
sono come i fiammiferi:
possono fare un po’ di luce,
ma è meglio non metterle
in mano ai bambini
(Non mi vergogno di confessare che mi era stato ispirato da una frase di Jacques Prévert: Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes – e anche da un “detto popolare” di notevole saggezza, che lascio scoprire alla memoria o all’immaginazione di chi legge).
Decisi anche che se avessi usato qualche esempio reale non solo avrei scatenato una serie di inutili polemiche, ma l’attenzione si sarebbe concentrata troppo sui casi specifici a scapito del concetto fondamentale. Mi sembrò meglio inventare due esempi palesemente immaginari, in un settore “impossibile” perché la pubblicità, già allora, era vietata: le sigarette.
(Decenni di divieto della pubblicità alle sigarette in Italia coincisero con un forte aumento dell’abitudine di fumare, specialmente fra i giovani, che cominciò a diminuire molto più tardi quando si diffuse una cultura, di origine americana, sui danni del fumo... intanto si era diffuso un altro tipo di “fumo”, di cui era ed è vietata non solo la pubblicità ma anche la vendita e il consumo... ma quella è un’altra storia).
L’ipotesi partiva da due dati reali. Alcune ricerche psicologiche erano arrivate alla conclusione che fumare era un atteggiamento fra il falsamente “eroico” e l’autodistruttivo, una sfida inconscia al rischio e alla morte. Altre lo descrivevano come un comportamento “orale e regressivo”, una specie di ritorno al seno materno.
Da qui il passo era facile: immaginiamo che un produttore di sigarette cada preda di qualche profeta “motivazionalista” e vediamo che cosa metterebbe sul mercato.
Dalla prima teoria, nasce un prodotto chiamato Makabro. Sigarette nere, con filtro color oro. Un pacchetto che potrebbe essere press’a poco così:
... e una pubblicità che dice più o meno così:

Dalla seconda ipotesi, invece, potrebbe nascere un prodotto chiamato Mamel. Sigarette con il filtro rosa-carne. Un pacchetto press’a poco come questo:
... e una pubblicità che dice più o meno così:

Assurdo? Ovviamente. Ma ci sono storie vere di progetti che sono arrivati “quasi” sul mercato, e anche di prodotti o campagne realizzate, che non sono molto meglio di così.
Trent’anni fa scrissi, in quell’articolo, che secondo me non avremmo mai visto sul mercato un prodotto come Mamel, ma che qualcosa di simile a Makabro poteva succedere, se non altro come scherzo o “ammonimento”. Infatti, molti anni più tardi, sono comparse davvero, qua e là, sigarette in lugubri pacchetti neri con teschio e tibie.
Un osservatore attento potrebbe chiedere: e se un prodotto “machista” sulla linea di Makabro interessasse alle donne? Probabilmente avrebbe ragione (per motivi che è facile intuire anche senza approfondite analisi psicologiche). Hanno avuto vita breve le sigarette “femminili” che qualcuno aveva lanciato anni fa in America. Ce ne sono ancora alcune (per esempio quelle lunghe e sottili) ma hanno una diffusione molto limitata. Ancora oggi molte donne fumano sigarette con un’impronta fortemente maschile – come Marlboro.
È tutto uno scherzo? Naturalmente. Ma il paradosso può essere un modo per esprimere un concetto serio. Se ci pensiamo un po’... ne possiamo dedurre, credo, alcune indicazioni che hanno un certo valore pratico. A cominciare dal fatto che tutte le ricerche (compresi talvolta gli approfondimenti psicologici) possono essere utili, ma non è quasi mai bene “prenderle alla lettera” o considerarle come il sostituto di un approfondimento strategico.
Quando scrissi il titolo di quel vecchio articolo, non avevo ancora letto una cosa abbastanza simile che disse David Ogilvy in quel periodo (e riconfermò anche molti anni più tardi):
Le ricerche sono come un lampione. Possono fare luce e aiutarci lungo la strada, ma non bisogna fare come l’ubriaco, che ci si appoggia.
Giancarlo Livraghi
gian@gandalf.it
Post scriptum
4 aprile 2006Sono passati otto anni dalla “nuova” pubblicazione di questo articolo – quasi quaranta dalla sua prima stesura. Molti segnali (compresi i commenti che ho ricevuto dai lettori) confermano che il problema è ancora di attualità (non solo nelle ricerche sulla comunicazione e negli studi sul comportamento umano, ma anche nella pratica clinica della psicologia).
Intanto in un recente dibattito televisivo si è detta una cosa che non avevo mai sentito prima: la frase di David Ogilvy sull’ubriaco che si appoggia al lampione sarebbe una citazione di George Bernard Shaw.
Quell’attribuzione è poco credibile. Altre fonti si riferiscono a nomi diversi e altrettanto improbabili. Ma è vero che David Ogilvy si era ispirato a un autore precedente. L’ipotesi più attendibile è che sia Mark Twain (si riferiva alle statistiche, non alle ricerche di mercato o alla psicologia – ma il concetto è lo stesso).
Comunque – e chiunque ne sia l’autore originale – rimane un pensiero intelligente e di notevole utilità pratica.