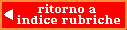Se una citazione o un’attribuzione imprecisa costituiscono di solito, per così dire, un peccato veniale privo di conseguenze, ciò non vale per la frase (ripetuta troppo, e spesso a sproposito) «il fine giustifica i mezzi».
Il concetto che essa esprime ha probabilmente origini antiche: lo si ritrova, ad esempio, nelle Heroides di Ovidio («exitus acta probat»).
L’affermazione suddetta, riferita nell’opinione comune a Niccolò Machiavelli, non trova però riscontro né nel Principe né in altre opere dell’autore. Inoltre non ne riflette il pensiero, anzi lo snatura e lo distorce, allo stesso modo dell’aggettivo “machiavellico” usato sempre con chiara connotazione negativa.
Ancor oggi Machiavelli è dunque, per i più, un cinico maestro di malvagità, di ipocrisia e di inganni finalizzati al conseguimento, con qualsiasi mezzo, di leciti o illeciti interessi personali.
Ma non fu questo il suo intento, né mai egli applicò alla propria vita la massima opportunistica che gli viene attribuita. L’avesse fatto, sarebbe potuto diventare ricco. Rimase invece sempre povero, malgrado la sua lunga attività in ambito diplomatico e politico.
Il motivo del perpetuarsi dell’errore è riconducibile in sostanza all’interpretazione frettolosa, superficiale o anche malevola e volutamente mistificatoria di un passo del 18o capitolo del Principe: «...nelle azioni [...] massime de’ principi [...] si guarda al fine.»
Il “fine” cui guardare, nell’ottica machiavelliana, è di natura esclusivamente politica e consiste nel raggiungimento del potere, nel suo mantenimento e nella solidità dello stato. Unicamente a tale scopo il principe deve saper «entrare nel male, necessitato»: nessuna sua azione, neppure la più riprovevole, può essere condannata se volta a «vincere e mantenere lo stato»: «i mezzi saranno sempre ritenuti onorevoli e da ciascuno laudati».
La stabilità, la grandezza ed il prestigio dello stato assumono pertanto, nel pensiero del Nostro, il valore di un ideale supremo e assoluto, di un mito in nome del quale tutto si giustifica.
Il celebre ritratto del principe (modellato in parte su Cesare Borgia) è grandioso e insieme terribile: all’apparenza fatta di lealtà, di benevolenza, di integrità, di umanità, di religiosità deve corrispondere, nella realtà, la forza spietata del “lione” unita all’astuzia sottile della “golpe”.
Solo la “fortuna” (cap.25o) è in grado di ostacolare la “virtù” del principe. Ma la fortuna “è donna” e come tale ama i giovani impetuosi che sanno dominarla ricorrendo alla violenza («è necessario [...] batterla e urtarla»): un’analogia che, pur risultandoci sgradevole o quanto meno assai discutibile, esprime con immediatezza vigorosa lo sforzo rinascimentale di rappresentare l’uomo, sempre e comunque, “faber fortunae suae”.
A fondamento della netta separazione tra la sfera morale e quella politica si colloca il profondo pessimismo nutrito da Machiavelli nei confronti della natura umana.
I miei precetti, egli insiste ripetutamente, non sarebbero buoni «se gli uomini fussino tutti buoni». Invece «nel mondo non è se non vulgo»: gli esseri umani sono (cap.17o) «ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori de’ pericoli, cupidi di guadagno», pronti a sostenerti nella buona sorte, a rivoltartisi contro nella cattiva. E «sdimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio».
Con sudditi siffatti, il principe che volesse «mantenere la fede e vivere con integrità e non con astuzia», come sarebbe “laudabile” (cap.18o), porterebbe ben presto alla rovina se stesso e il proprio stato.
Ma c’è di più: nel capitolo finale (26o) emerge con una potenza tanto intensa quanto inaspettata il sentimento animatore del trattato, sul quale viene così gettata una luce del tutto nuova.
Lungi dall’essere una fredda disamina della “verità effettuale della cosa” o tanto meno un immorale prontuario di malefatte ad uso e consumo dei potenti, esso si rivela il frutto del dolore per le tragiche condizioni dell’Italia del tempo – e della speranza (riposta nel casato dei Medici) che essa, «sanza capo, sanza ordine; battuta, spogliata, lacera, corsa», trovi la propria salvezza nell’agire deciso e spregiudicato di un principe audace e forte, capace di liberarla dalle odiose dominazioni straniere: «A ognuno puzza questo barbaro dominio».
Machiavelli non rinnega nel Principe i propri ideali repubblicani, di cui i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio sono un’evidente testimonianza: la repubblica tuttavia potrà rinascere, a suo giudizio, solo dopo che il principato avrà posto le basi per la sua rigenerazione.
Flavia Tornari Zanette
Una piccola nota: la repubblica italiana si è realizzata 430 anni dopo.
[g.l.]
Non resisto alla tentazione di aggiungere un commento
che riguarda un altro fra i più orribili modi di dire.

Titus Flavius Vespasianus
“Pecunia non olet”
Il problema, in questo caso, non è l’attribuzione. Ma è il significato, metaforico e molto più esteso, che la frase ha assunto nei (quasi venti) secoli successivi all’episodio narrato da Svetonio e Dione Cassio.
È rimasto anche in epoca moderna l’uso di chiamare “vespasiano” un pubblico “servizio igienico” (di uso solo maschile). L’etimologia è corretta. Fu davvero quell’imperatore a deciderne l’installazione a Roma. Ma, per quanto bene intenzionata, la cosa suscitò alcuni problemi e polemiche.
Pare che il servizio fosse a pagamento – in alcune situazioni obbligatorio (per esempio prima di accedere a cerimonie di stato). Gestito da privati, gravati di una tassa da cui provenivano cospicue entrate per l’erario.
C’era anche un sistema di raccolta delle urine con procedimenti chimici per ricavarne l’ammoniaca, usata nella concia delle pelli.
Insomma un esteso e complesso giro di denaro, fra pubblico e privato, in cui si insinuavano problemi di corruzione e ogni sorta di altri abusi.
Fra i critici della contorta situazione c’era Tito, figlio di Vespasiano (e più tardi suo successore sul trono). Gli storici raccontano che, in dileggio al padre, Tito buttò alcune monete in una delle latrine – e Vespasiano con altrettanto scherno le raccolse dicendo “il denaro non puzza”.
Ne possiamo dedurre che all’epoca dei Flavi i governanti avessero un senso dell’umorismo di cui si trova scarsa traccia in altri periodi storici, compreso quello in cui viviamo. E oggi il fetore fisico è meno diffuso. Ma, per il resto, mi sembrano evidenti le sgradevoli somiglianze con il mondo attuale.
Giancarlo Livraghi